Già a partire da “Lavorare stanca” iniziano a delinearsi delle coppie antitetiche,  opposizionali, su cui Pavese andrà a strutturare le opere successive: campagna e città, collegate da una serie di passaggi e gradazioni intermedie (la collina torinese, il fiume, la periferia, con i relativi personaggi tipizzati, operai, prostitute, suonatori e frequentatori di osterie); ozio e lavoro, insieme con le varianti evasione ed impegno, individualismo e socialità; infanzia e maturità, di cui la prima è intesa come momento magico e privilegiato, mitico, di una scoperta dei sensi e delle cose, come adesione spontanea alla realtà e al mondo circostante; la seconda come sconfitta e delusione, ripiegamento, scoperta di una infelicità di fondo popolata di fantasmi interiori.
opposizionali, su cui Pavese andrà a strutturare le opere successive: campagna e città, collegate da una serie di passaggi e gradazioni intermedie (la collina torinese, il fiume, la periferia, con i relativi personaggi tipizzati, operai, prostitute, suonatori e frequentatori di osterie); ozio e lavoro, insieme con le varianti evasione ed impegno, individualismo e socialità; infanzia e maturità, di cui la prima è intesa come momento magico e privilegiato, mitico, di una scoperta dei sensi e delle cose, come adesione spontanea alla realtà e al mondo circostante; la seconda come sconfitta e delusione, ripiegamento, scoperta di una infelicità di fondo popolata di fantasmi interiori.
Quindi, se la città rappresenta il luogo dell’inautenticità e della solitudine, la campagna, al contrario, sembra promettere una pienezza di manifestazioni vitali, diventando sede dei valori e dei riti perduti sotto l’incalzare schiacciante di una civiltà industriale.
La campagna delle Langhe piemontesi è un mondo a sé stante, ancora chiuso in una sfera mitica di sesso e sangue che vanno a trovare una corrispondenza negli antichi rituali che restano a sedimentare nel presente; la collina è dunque il selvaggio, lo sconosciuto, l’atavico, una presenza costante che incombe sulla città, qualcosa da cui non si può scappare: tutto tende ad essa;
Ricordiamo la costante presenza della collina nel ciclo “la bella estate” di ambientazione borghese, in tutta la sua produzione poetica, da “Paesi tuoi” fino ad arrivare al culmine raggiunto con “La luna e i falò”.
Il dialetto è lingua antica, sconosciuta, profonda, ritmata, mistica, come lo può essere il greco, o le lingue antiche che racchiudono in sé tutto il mistero dei riti rurali.
In quest’ottica, Langhe e mito sono due realtà che coesistono nello stesso piano; altro rispetto ad una modernità mortifera, propongono dei riti e dei valori di grande naturalità e violenza vitale: la natura è spargimento di seme e di sangue.
La collina è dunque Radice.
“I popoli che praticarono i più atroci e frequenti sacrifici umani furono gli agricoltori (civ. matriarcali). Né i pastori, né i cacciatori, né gli artigiani furono mai crudeli come i contadini”. 16 gennaio 1945
Elemento essenziale della produzione letteraria di Pavese è la riflessione sul mito: sulla scorta di Jung, lo scrittore concepisce il mito come archetipo, simbolo primordiale radicato nell’inconscio collettivo dell’umanità, e dunque elemento comune ed universale, ma anche oscuro e misterioso. Compito dell’arte è rendere chiara tale materia informe, dandole una forma ordinata e razionale: da qui nasce il travaglio che accompagna la scrittura, intesa come “mestiere”; il mito è dunque materia informe alla quale la poesia da voce. Pur basandosi su una realistica situazione storica e geografica, i personaggi, gli ambienti e le vicende rimandano ad una trama di elementi simbolici.
“Tutto è ripetizione, ripercorso, ritorno. Infatti anche la prima volta è una “seconda volta”
6 novembre 1943
“Non esiste “vedere le cose la prima volta”. Quella che ricordiamo, che notiamo, è sempre una seconda volta” 26 settembre 1942
L’interesse nei suoi confronti, che nasce dalla lettura di autori classici e moderni (Nietzsche, D’Annunzio, Mann), viene approfondito dallo studio di testi specialistici di tipo etnografico e antropologico, dando vita, nel dopoguerra, ad alcuni saggi teorici.
Nel saggio “Del mito, del simbolo e d’altro”, Pavese scrive:
“Ora, carattere, non dico della poesia, ma della fiaba mitica è la consacrazione dei luoghi unici, legati a un fatto a una gesta a un evento. A un luogo, tra tutti, si dà un significato assoluto, isolandolo nel mondo. Così sono nati i santuari. Così a ciascuno i luoghi dell’infanzia ritornano alla memoria; in essi accaddero cose che li han fatti unici e li trascelgono sul resto del mondo con questo suggello mitico.”
Con la teoria del mito Pavese fissa e definisce le sue originarie intuizioni dell’infanzia e del paesaggio ad esso legato: la fanciullezza è il momento privilegiato, in cui il mito viene vissuto spontaneamente ed inconsapevolmente; quando ci si rende conto di questo, l’infanzia è già perduta.
Inoltre il mondo infantile gioca un ruolo fondamentale nella crescita dell’individuo in quanto lo determina; in questo rapporto consiste il “destino” dell’uomo, per il quale ogni ricerca di sé porta sempre ad un ritorno alla radice. Da qui il grande valore consegnato al “rustico” e al “primitivo”, proiettati nelle Langhe, che si popolano di figure bestiali e ferine (fondamentale è l’influsso di Giambattista Vico, già trovato nel meccanismo ripetitivo dell’errare, che nella “Scienza nuova”, aveva definito la fanciullezza dell’uomo “l’età degli dei”, la “barbarie eroica”, in cui si formano i miti dell’umanità). Così la collina diventa il luogo mitico e “unico”, e le vicende di cui sarà teatro, avranno un valore eccezionale, irripetibile e grottesco, assumendo una dimensione profondamente simbolica.
“Ieri sera vento caldo, letto miti e leggende africane. È mattino azzurro, fresco e giallo di sole. Le leggende sono la storia di ciò che avviene la prima volta e ne hanno la semplicità e lo stupore. Anche se raccontano un fatto non iniziale il tono è questo: semplice designazione mai descrizione, non aggettivi; struttura ritmica che costituisce il dramma, la sospensione.”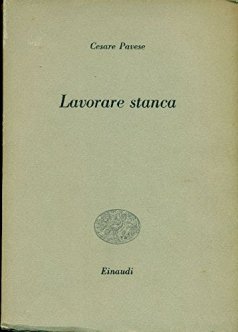
Prendiamo in esame la poesia “ I mari del sud”, che apre la prima raccolta “Lavorare stanca”, “troviamo tutte le tematiche sue proprie: la terra, l’amore, la morte, il sangue, le radici, la perdita delle radici, la partenza, il ritorno sofferto.
Innanzitutto la figura del cugino viene proiettata in un alone quasi mitico, il “gigante vestito di bianco, che si muove pacato, abbronzato nel volto, taciturno” con un’amplificazione luminosa dell’immagine, e rappresenta la forza e il coraggio di chi ha vissuto pienamente la vita, dura e avventurosa lontano dalla propria terra, per poi farvi ritorno e riscoprire dolorosamente le proprie radici. Si scorge alla fine della poesia la figura del baleniere tanto stimato da Pavese:
“ …Solo un sogno
Gli è rimasto nel sangue: ha incrociato una volta
Da fuochista su un legno olandese da pesca, il Cetaceo,
e ha veduto volare i ramponi pesanti del sole,
ha veduto fuggire balene tra schiume di sangue
ed inseguirle e innalzarsi le code e lottare alla lancia.
Me ne accenna talvolta”
La passeggiata del poeta e del cugino sulle colline, “nell’ombra del tardo crepuscolo”, introduce subito il motivo del silenzio, che mitizza il tema della solitudine e dell’incomunicabilità riportandolo alle caratteristiche della gente contadina:
“…Tacere è la nostra virtù.
Qualche nostro antenato dev’essere stato ben solo
-un grand’uomo tra idioti o un povero folle-
per insegnare ai suoi tanto silenzio”
E ancora viene rimarcato il carattere profondo della terra, incontaminata e selvaggia, completamente avulsa dalla realtà urbana:
“… Spiegò poi a me,
quando fallì il disegno, che il suo piano
era stato di togliere tutte le bestie alla valle
e obbligare la gente a comprargli i motori”
la contrapposizione Langhe-città, accennata in una prospettiva paesaggistica:
“dalla vetrata si scorge
nelle notti serene il riflesso del faro
lontano, di Torino”
trova nella quarta strofa una sua più complessa e rilevante definizione
“Oh da quando ho giocato ai pirati malesi,
quanto tempo è trascorso. E dall’ultima volta
che son sceso a bagnarmi in un punto mortale
e ho inseguito un compagno di giochi su un albero
spaccandone i bei rami e ho rotta la testa
a un rivale e son stato picchiato,
quanta vita è trascorsa. Altri giorni, altri giochi,
altri squassi del sangue dinanzi a rivali
più elusivi: i pensieri ed i sogni.
La città mi ha insegnato infinite paure:
una folla, una strada mi han fatto tremare,
un pensiero talvolta, spiato su un viso.
Sento ancora negli occhi la luce beffarda
dei lampioni a migliaia sul gran scalpiccìo”
È il rumore della folla che percorre le strade cittadine ad accentuare il sentimento di profonda solitudine del poeta, ormai diventato adulto e staccatosi dal mondo della campagna; il binomio maturità-infanzia si articola su due livelli: il bambino, sicuro di sé, che fantastica di avventure marine, è opposto al cugino, il titano, che le avventure le ha vissute, ma non è riuscito ad ottenere la tanto agognata sicurezza (“la città mi ha insegnato infinite paure”).
Nella conclusione si spiega la radice sociologica della differenza fra i due personaggi: l’aurora.
Laddove uno la intende esteticamente, come insegnavano i romanzi d’avventure tanto amati, per l’altro non scandisce più neanche il ritmo del lavoro.
“Ma quando gli dico
ch’egli è tra i fortunati che han visto l’aurora
sulle isole più belle della terra,
al ricordo sorride e risponde che il sole
si levava che il giorno era vecchio per loro.”
Una poesia di stampo tipicamente mitico è sicuramente “Il dio-caprone “, in cui la campagna, d’estate, sprigiona tutta la sua forza e vitalità, il mistero dell’invasamento, una frenetica energia vitale che investe ogni cosa, culminante in una danza sabbatica che media il motivo centrale del sesso attraverso la presenza degli animali, simbolo di forze demoniache e irrazionali.
“Al levar della luna le capre non stanno più chete,
ma bisogna raccoglierle e spingerle a casa,
altrimenti si drizza il caprone. Saltando nel prato
sventra tutte le capre e scompare. Ragazze in calore
dentro i boschi ci vengono sole, di notte,
e il caprone, se belano stese nell’erba, le corre a trovare.
Ma, che spunti la luna: si drizza e le sventra.
E le cagne, che abbaiano sotto la luna,
è perché hanno sentito il caprone che salta
sulle cime dei colli e annusato l’odore del sangue.
E le bestie si scuotano dentro le stalle.
Solamente i cagnacci più forti dàn morsi alla corda
e qualcuno si libera e corre a seguire il caprone,
che li spruzza e ubriaca di un sangue più rosso del fuoco,
e poi ballano tutti, tenendosi ritti e ululando alla luna.”
Scritto nel 1939 e dato alle stampe nel 1941, “Paesi tuoi” introduce vistosamente la dimensione del mito, facendo delle Langhe un ambiente primitivo e selvaggio, percorso da immagini di fuoco, i falò, e di sangue, i sacrifici.
“La natura ritorna selvaggia quando vi accade il proibito: sangue o sesso. Parrebbe un’illusione suggerita dall’idea che ti fai delle culture primitive- riti sessuali o sanguinari.
Donde si vede che selvaggio non è il naturale ma il violentemente superstizioso. Il naturale è impassibile. Che uno cada da un fico in una vigna e giaccia a terra nel suo sangue non ti pare selvaggio come se costui fosse stato accoltellato o sacrificato. Superstizioso è chiunque cede alla passione bruta”. 13 luglio 1944
Innanzitutto, l’immagine della collina-mammella, costantemente presente, richiama alla profonda natura sessuale del luogo; inoltre si stabiliscono relazioni ricorrenti tra Gisella, la frutta e le mele:
“quella sera non veniva più notte,e la vecchia mi trova nella stanza delle mele, mi chiede chi ero perché al chiuso non ci vedeva più bene. Io le dico che mangio una mela di sua figlia, se è permesso, per lavarmi la bocca.”
In questo gioco di rimandi sessuali è la chiave delle corrispondenze simboliche che, a loro volta, rimandano alla tragica conclusione, quando la violenza e la bestiale passione elementare portano Talino ad uccidere la sorella: l’acqua del secchio si rovescia e, con il sangue, impregna la terra, violenza sanguinosa già sottolineata con l’allusione alla violenza incestuosa di Talino.
“Ma Gisella tossiva e vomitava sangue, e quel fango era nero”
Pavese si è sforzato di adattare i riti primitivi all’ambiente rustico della campagna, trasferendovi i tabù ancestrali dell’incesto e del sangue. La presenza di significati sessuali si sprigiona nei modi e nelle forme di una violenza che, dapprima repressa, si scatena e diviene istinto ferino nel momento di massima esplosione delle energie vitali della terra.
La follia di Talino affonda le radici in numerosi esempi mitici, basti pensare alle Baccanti di Euripide che fanno a brandelli il corpo di Penteo; o ancora, troviamo nel dialogo “L’ospite” un baldanzoso Litierse che parla così ad Eracle riguardo i sacrifici umani:
“ Non ci venne nessun forestiero. Uccidemmo un vecchio servo e un caprone. Fu un sangue molle che la terra sentì appena. Vedi la spiga, com’è vana? Il corpo che noi laceriamo deve prima sudare, schiumare nel sole. Per questo ti faremo mietere, portare i covoni, grondare fatica, e soltanto alla fine, quando il tuo sangue sarà vivo e schietto, sarà il momento di aprirti la gola. Tu sei giovane e forte”
Un altro elemento ricorrente è l’incendio, il fuoco, il falò, già accennato in “Paesi tuoi”, appare chiaro ne “La luna e i falò” e, ancora di più, nell’opera più propriamente di stampo mitico:”Dialoghi con Leucò”.L’incendio della Grangia, l’incendio della Gaminella, i falò, l’epilogo di Santa, sono tutti episodi che richiamano al tempo remoto degli antichi rituali sanguinari degli spargimenti di sangue, dei roghi propiziatori, dei sacrifici umani, i falò che nutrono madre terra.
Romanzo strettamente legato al mito, “La luna e i falò”, scritto nei primi mesi del 1949 e pubblicato nel 1950, conclude la carriera narrativa dello scrittore.
I temi fondamentali sono quelli già indagati ne “I mari del sud”: il mito e la radice, la terra.
Il paese, il luogo dove si nasce e si muore.
“Un paese ci vuole, non fosse altro che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.
Anguilla, il protagonista, torna al suo paese natio dove ha vissuto da bastardo, dall’America, quell’America così grande, vuota e selvaggia: l’antipaese.
Egli soffre questo suo essere bastardo, senza radici, senza luogo, senza un vero ritorno:
“C’è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo; dove son nato non lo so; non c’è da queste parti una casa né un pezzo di terra né delle ossa ch’io possa dire “ecco cos’ero prima di nascere”. Non so se vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del duomo di Alba, magari non veniva neanche dalla campagna, magari era la figlia dei padroni di un palazzo, oppure mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere donne da Monticello, da Neive o perché no da Cravanzana. Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione”
Ma il ritorno e il tuffo nel passato non è un semplice viaggio indietro nella memoria, come un recupero di un tempo antico e favoloso, bensì è un viaggio alle origini che consente a Pavese di rilevare il sostrato mitico-simbolico della realtà, alle azioni dell’uomo, alle vicende del presente e del passato, si intravvedono certi simboli universali e perenni del destino umano. In quest’ottica, Nuto, l’amico rimasto fedele alla terra, è il suo duca, il suo Virgilio.
Ma in quel mondo, così diverso eppure così uguale, fallisce il tentativo di ritorno, deludente e angosciante.
Già dal titolo, “la luna”, “i falò”, chiari riferimenti mitici, la cui presenza accompagna, seguendo il ciclo delle stagioni, le vicende del destino umano. L’eco è quello del “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” leopardiano, dove l’astro offre uno spunto di riflessione sul senso della vita.
Il valore simbolico della luna è quello di evidenziare il ritmo interno dell’opera, attraverso un rapporto terra-cielo; nel primo elemento, si riflettono i bagliori dei fuochi accesi dai contadini durante le feste paesane, retaggio atavico di una cultura rustico-popolare legata ai riti della terra che, per il giovane, hanno rappresentato un momento magico di scoperta e possesso della vita.
Ai falò dell’infanzia si contrappongono altri falò, che comportano la perdita delle illusioni del protagonista e la sua decisione di abbandonare il paese.
L’incendio appiccato dal Valino alla Gaminella che, invasato da un’energia di brutale ferocia, uccide le donne e si suicida, distruggendo così le ultime tracce del passato e della sua disperazione. O ancora la vicenda di Santa, che il protagonista aveva lasciato che era ancora bambina, diventata una bellissima ragazza inizia a mettersi in una situazione più grande di lei, fra le camicie nere e la resistenza.
Il romanzo si chiude con le parole di Nuto, l’amico rimasto fedele alla terra, che racconta l’epilogo della ragazza:
“-No, Santa no, – disse – non la trovano. Una donna come lei non si poteva coprirla di terra e lasciarla così. Faceva ancora gola a troppi. Ci pensò Baracca. Fece tagliare tanto sarmento nella vigna e la coprimmo fin che bastò. Poi ci versammo la benzina e le demmo fuoco. A mezzogiorno era tutta cenere. L’altr’anno c’era ancora il segno, come il letto di un falò.”
Dialoghi con Leucò, l’opera più propriamente di carattere mitico, è il testamento intellettuale dell’autore, in cui indaga tutti i temi a lui cari sul mito, sulla natura, sul destino e sull’uomo.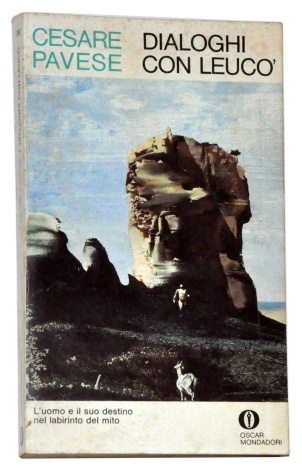
Dalla prefazione de “Il mistero”:
“Che i misteri eleusini presentassero agli iniziati un divino modello dell’immortalità nelle figure di Dioniso e Demetra (e Core e Plutone) piace a tutti sentirlo. Quel che piace di meno è sentir ricordare che Demetra è la spiga – il pane- e Dioniso, l’uva – il vino. “Prendete e mangiate…”
Nel dialogo “Il lago”, nella figura di Virbio-Ippolito, morto, e risorto per mano di Artemide, vive sui monti Albani, solo, al pari della lepre o della nube, “l’oggi aggiunge qualcosa al suo ieri?”:
“o Selvaggia, non so. Sembra ieri che aprii gli occhi quaggiù. So che è passato tanto tempo, e questi monti, quest’acqua, questi alberi grandi sono immobili e muti. Chi è Virbio? Sono altra cosa da un ragazzo che ogni mattina si ridesta e torna al gioco come se il tempo non passasse?”
La dea replica:
“Questa non è una terra dei morti, ma il vivo crepuscolo di un mattino perenne. Non hai bisogno di ricordi, perché questa vita l’hai sempre saputa”
Emerge la forte dicotomia fra il necessario bisogno di compagnia, e la solitudine esistenziale dell’autore:
“Diana: Pensaci bene, Virbio-Ippolito. Tu sei stato felice.
Virbio: Non importa, signora. Troppe volte mi sono specchiato nel lago. Chiedo di vivere, non di essere felice.”


Chapeau!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Ché da tutte le cose
siamo sempre fuggiti
irrequieti e insaziati
sempre portando nel cuore
l’amore disperato
verso tutte le cose.
Cesare Pavese – Il mestiere di vivere: Diario 1935-1950.
"Mi piace"Piace a 3 people
Pavese è sempre grande ❤
"Mi piace"Piace a 2 people
Complimenti per la magnifica analisi.
Splendidamente colto il fascino della collina-vita, rispetto alla città fredda.
"Mi piace"Piace a 1 persona
grazie mille, sono comtento sia piaciuto. In effetti ci ho lavorato un sacco
"Mi piace"Piace a 1 persona
Sono piemontese anch’io i miei nonni avevano ampi terreni nell’astigiano dov’è da bambini ci mandavano con la donna di servizio a passare l’estate ed erano estate di fuoco e per quanto innocenti noi fossimo l’odore del sesso del mistero aleggiava ovunque.
Uno scritto coinvolgente il tuo che mi ha portato indietro negli anni (ne ho 55). Quanto si è perso!
Sherazadenomorewords
"Mi piace"Piace a 1 persona
sono contento ti sia piaciuto, e sì, tanto tempo è passato ormai, e molto si è perso
"Mi piace""Mi piace"
…ed io da 30 sono romana!
"Mi piace"Piace a 1 persona
Splendida dissertazione. Servirebbe farla presente alle scuole come spunto per dibattiti con i ragazzi. Complimenti davvero. Isabella
"Mi piace"Piace a 2 people
ti ringrazio, ne sono lusingato, e pensare che sono uscito da poco dalla scuola ahahah
"Mi piace"Piace a 1 persona
Allora ho colto quasi nel segno. Si vede che nonostante l’età , ho un sesto senso ancora funzionante. Comunque adesso non credere ch’io sia ottuagenaria eh ? Ah, ah, ah . Buona giornata doveck. Isabella
"Mi piace"Piace a 1 persona
I luoghi di Pavese hanno dapprima infiammato la mia immaginazione di adolescente. Succedeva allora – sto parlando degli anni Settanta – che se iniziavi a leggere un libro di un autore diventava importante poi leggerli tutti: era normale procedere in questo modo, diventava parte della tua formazione intellettuale. Prima ” La luna e i falò” e poi tutti gli altri. Mi aveva colpito anche la sua fine e il biglietto scritto ad accompagnarla: “Perdono tutti e a tutti chiedo perdono”. Poi i suoi luoghi, a cominciare da Santo Stefano Belbo, li ho vissuti in prima persona perché lo Stato mi impose 20 mesi di servizio civile ad Alba e intorno a Alba ci sono i seni delle Langhe che come Cesare trovai aridi e per niente materni. Con me porto ” Dialoghi con Leucò”, il libro che più mi ha colpito e che mi ha insegnato il dialogo costante con il mito e la possibilità di riallacciarne i fili con la realtà quotidiana. Se due libri, assolutamente atipici per la letteratura italiana, vale la pena riscoprire, questi sono “Operette morali” di Leopardi e proprio ” Dialoghi con Leucò” di Pavese. Portare avanti la riflessione attraverso i dialoghi è rivoluzionario in quest’epoca in cui tutto viene selfizzato ed ognuno è chiuso in una struttura comunicativa del tutto fittizia. Per non parlare dell’erezione di muri e del rifiuto dell’accoglienza. Grazie per il bell’articolo! paolo.gera@tin.it
"Mi piace"Piace a 3 people
molto interessante. Grazie per questa piacevole lettura Vittoria R.
"Mi piace"Piace a 1 persona
grazie mille, mi fa molto piacere che ti sia piaciuto
"Mi piace""Mi piace"
Quanto amo “I Dialoghi con Leucò”…Hai scritto un articolo bellissimo. E io, prima o poi, spero, riuscirò a fotografare le Langhe.
"Mi piace"Piace a 1 persona
i dialoghi sono il suo testamente spirituale, qualcosa di incredibile, grazie per i complimenti e spero anch’io di riuscire a fotografarle
"Mi piace"Piace a 1 persona
Ho anch’io quella vecchia edizione dei Dialoghi e non immagini quante volte l’ho letta e riletta nel corso degli anni. Ero una ragazzina, allora, ed ero molto simile a quella che lui descrive nella sua poesia che certamente ricorderai… “..la magra bambina che fui…” Anch’io scendo in strada a cercare i colori (è una cosa che faccio da una vita, anche se poi le foto le converto in b&n ). 🙂
"Mi piace"Piace a 1 persona
erano altri tempi, un’altra poesia
"Mi piace""Mi piace"